Charleston, East Sussex. Una casa di campagna viene scelta da Vanessa Bell, sorella di Virginia Woolf, come rifugio lontano da Londra. È da ristrutturare ma ha un bel giardino, uno stagno, stanze spaziose.
1916. Da due anni si combatte sui vari fronti. La Prima Guerra Mondiale è lo sfondo che accompagna gli inizi della vita a Charleston da parte di Vanessa che vi si trasferisce con i due figli, il compagno Duncan Grant e il giovane David Garnett.
Il libro di Mario Fortunato, “Il Giardino di Bloomsbury”, inizia nell’estate del 1916 per concludersi ventun capitoli dopo nella primavera del 1961 quando Nessa, ormai ottantenne, si spegne nella sua camera da letto pensando alla nuova personale alla Adams Gallery di Londra e ai vecchi amici, i pochi ancora viventi e quelli che se ne sono già andati e che con lei, in quella casa, in tutti quegli anni, avevano condiviso idee, amori, arte, stravaganze, successi, litigi, provocazioni.
Amici fuori del comune che oggi tutti ricordano come “il Gruppo di Bloomsbury”, pensando soprattutto a nomi noti come Virginia Woolf, John Maynard Keynes o Bertrand Russell, senza ben ricordare chi fossero gli altri giovani talentuosi frequentatori della casa di Bloomsbury a Londra o a quella di Charleston in campagna.
Il merito del libro di Mario Fortunato è quello di farceli conoscere uno ad uno nella loro quotidianità condivisa, nella peculiarità del loro talento, nei complicati intrecci amorosi vissuti in un contesto di estrema libertà, di ribellione contro le rigide convenzioni imposte dalla tradizione vittoriana, nell’indifferenza dei giudizi altrui e senza pretese pedagogiche.
Persone che nel libro son chiamate per nome come se fossero amici anche nostri, Lytton (Strachey, scrittore, critico letterario), Roger (Fray, critico d’arte), Morgan (Foster, scrittore), Leonard (Woolf, scrittore, editore, marito di Virginia), Maynard (Keynes, economista), Bunny (David Garnett, scrittore), mentre Dora (pittrice), viene semplicemente citata come Carrington, perché così aveva deciso di farsi chiamare anche nella vita.
Il tema dell’amicizia attraversa i tanti ritratti proposti in forma di romanzo. Racconti che ci fanno rivivere quel mondo, fotografie che danno un volto ai nomi, mappe dell’edificio e del giardino di Charleston che orientano il lettore negli spazi di una casa diventata non solo luogo di vita ma anche opera d’arte totale grazie alla pittura di Vanessa e di Duncan che ridipinsero e reinventarono pareti, oggetti, mobili.
Il prologo introduce alla lettura descrivendo la prima visita di Mario Fortunato in gioventù davanti alla casa disabitata, con porte e finestre sbarrate. L’epilogo vede il ritorno a Charleston dello scrittore ormai adulto nello stesso luogo, nelle stanze che avevano ripreso a vivere per i visitatori, spazi consacrati alla vita e al lavoro, contenitori del “romanzo di ogni esistenza” compresa quella dell’autore.




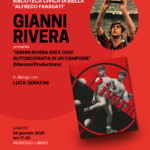



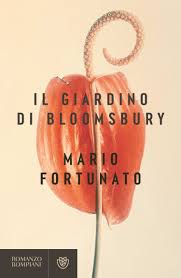
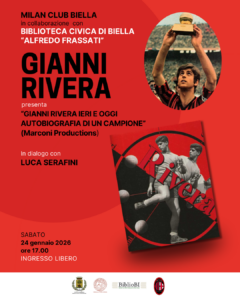





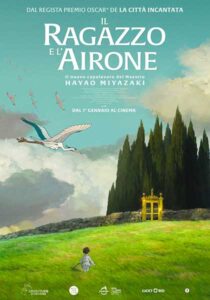

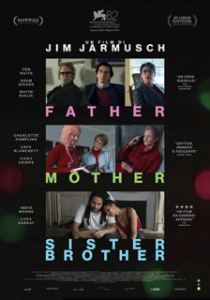







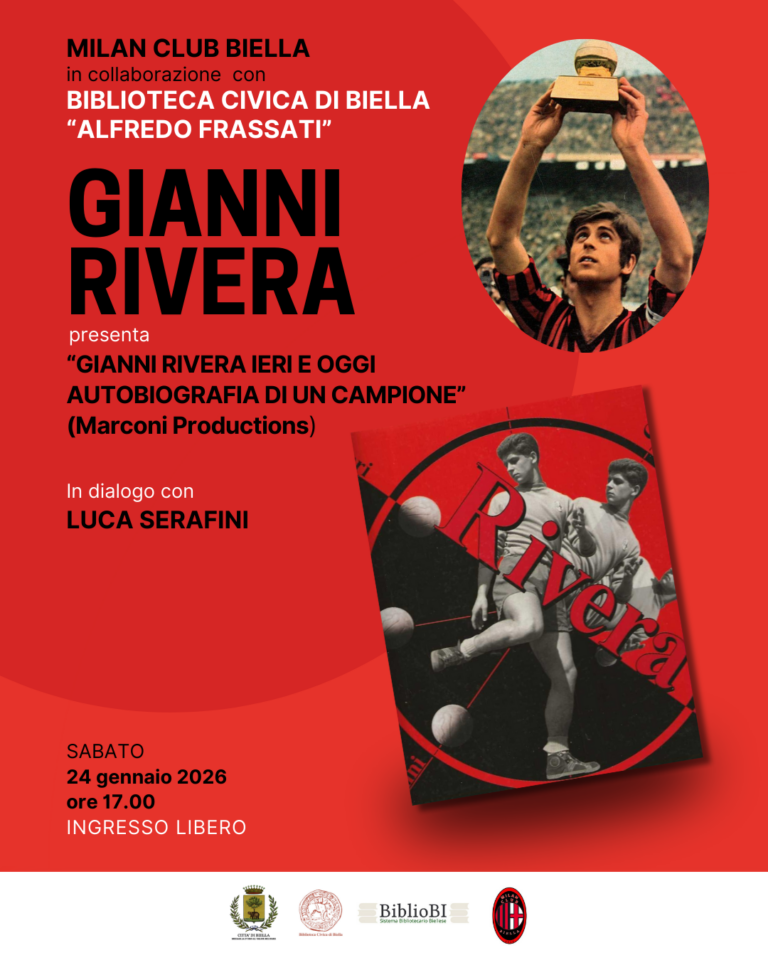


+ There are no comments
Add yours